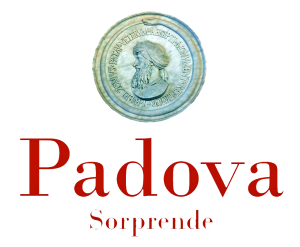Sommario
Abstract
Il maestoso portale del santuario di Monteortone (Abano), in pietra d’Istria, affiancato da due colonne corinzie sopra alti piedistalli e sormontato da splendide statue, per oltre 9 anni (dal 1663 al 1672), fu causa di una lunga lite tra i padri agostiniani dell’attiguo convento, gli architetti-scultori e l’erede del mecenate che si era assunto l’onere economico dell’opera. Dai documenti conservati presso l’Archivio di Stato di Padova, emerge che il contenzioso si trascinò a suon di fendenti legali o, come si direbbe oggi, “a colpi di carte bollate”, con spreco di vertenze, diffide, ingiunzioni, perizie, processi, sentenze e relativi ricorsi. Propizio e decisivo fu l’intervento dell’architetto Baldassare Longhena.
L’idea del progetto. A chi assegnare l’incarico?

Tutto inizia nel 1662, quando gli agostiniani pensano di far costruire un magnifico portale per abbellire il santuario. Nella comunità monastica di Monteortone alcuni frati possiedono una buona cultura e un gusto spiccato per l’arte, per cui l’idea del nuovo portale, lanciata dal padre priore, viene accolta quasi senza riserve dai suoi più stretti collaboratori, tanto che qualche monaco, rimboccatesi subito le maniche, si siede al tavolo per preparare un bozzetto da proporre alla comunità.
I pareri e i suggerimenti non mancano, ma il primo scoglio da superare è quello di reperire un’adeguata somma per la parcella dell’architetto, a cui assegnare il progetto dell’opera: dovrebbe trattarsi di un professionista d’alto livello e, possibilmente, noto nell’ambiente veneto. Purtroppo, in questo periodo le rendite del convento scarseggiano, anche perché le offerte dei fedeli e dei benefattori sono drasticamente diminuite. L’economo, infatti, fa presente che le casse e le dispense contengono appena il necessario per far fronte alle elementari esigenze della vita quotidiana. Il priore, allora, propone di rivolgere un’accorata supplica al doge. Ma perché proprio a Sua Serenità Domenico Contarini, e non direttamente al podestà di Padova Michele Morosini? Il motivo è semplice, e ci riserviamo di spiegarlo qualche riga più sotto.
Inizia, da questo momento, uno scambio epistolare tra i monaci e l’ufficio del Maggior Consiglio della Repubblica, così che, il 12 aprile 1663, dal palazzo ducale di Venezia parte una lettera indirizzata al podestà della Città del Santo e al suo capitano Simone Contarini. Eccone il contenuto:
Il senato veneto, presieduto dal serenissimo principe, ha stabilito che i rettori di Padova applichino, a beneficio del santuario di Monteortone, e in particolare per la realizzazione del nuovo portale, la somma di trecento ducati, che dovranno essere prelevati dalle sanzioni inflitte ai trasgressori delle leggi veneziane. È significativa la nota con cui si chiude la missiva: “L’opera servirà ad esaltare il nome della Santissima Vergine”.
Di solito, alle richieste di denaro da parte di privati – e per il Comune di Padova gli agostiniani di Monteortone sono a torto considerati tali –, gli amministratori pubblici tendono a nicchiare, a tergiversare, ad accampare impedimenti di vario genere, per poi rispondere negativamente – la qual cosa, per la verità, avviene anche ai nostri giorni –, ma ora, di fronte all’ordine del doge, sono costretti ad abbassare il capo e, benché le casse comunali in questo momento non siano particolarmente floride, devono trovare il modo di risolvere il problema. Ma come? Poiché le sole multe dei condannati costituiscono una risorsa finanziaria scarsamente significativa, bisognerà estrarre una cospicua parte di denaro dal magico cilindro, quello che – si dice – quasi tutte le amministrazioni locali custodiscono in una stanza segreta. Sta di fatto che, anche questa volta, grazie all’intervento della Repubblica Veneta, i frati raggiungono il loro obiettivo.
I rettori e gli amministratori padovani, ritenendosi autorizzati a prendere in mano le redini dell’iniziativa, incaricano un architetto di Padova, certo Antonio Zanin, affinché predisponga un bozzetto del portale, accompagnando il progetto con una dettagliata relazione. Ma, da questo momento, cominciano i guai, perché gli agostiniani, che hanno una loro precisa idea di come dovrà essere l’opera, arricciano il naso. Accantonato, infatti, il disegno di Zanin, ne fanno predisporre un altro, spiegando che la struttura architettonica dovrebbe essere in pietra d’Istria ben lavorata; che una statua della Madonna con il Bambino in braccio si dovrebbe collocare al centro, mentre ai lati vi dovrebbero apparire “duoi Arcangiolli di grandezza al naturale e duoi Angelli fentatti a’ piedi del piediftallo nella proportione et modo difegnati” (“due arcangeli di grandezza naturale e due angeli ai piedi della base, nelle proporzioni e nel modo con cui sono disegnati”).
Il nuovo studio, che arriva sul tavolo del priore, è dei fratelli Matteo e Tommaso Allio, ma non sappiamo se commissionato dal podestà, o richiesto dagli stessi monaci, o se spontaneamente proposto dai due professionisti, peraltro molto conosciuti a Padova. In ogni modo, quest’ultimo progetto è senz’altro gradito ai religiosi, che non esitano ad approvarlo, per quanto, nel fondo delle loro coscienze, non abbiano ancor ben digerita la clausola secondo cui il denaro da destinarsi al professionista si dovrebbe prelevare dalle multe dei contravventori della legge e dai condannati. E perciò, quando si fa vivo un certo Gianmaria Grigno, da Cittadella, per sovvenzionare l’intera opera, i buoni monaci tirano un sospiro di sollievo.
Un mecenate e il suo erede. Iniziano i guai.

Ma chi è Gianmaria Grigno? e perché interviene nella trattativa con tanta generosità? Per rispondere a queste domande, dobbiamo indietreggiare di qualche anno ed entrare in casa di un certo dottor Giovanni Galvan, un signore piuttosto agiato che è al corrente del desiderio dei frati di adornare il santuario con un maestoso portale. Non avendo prole e prevedendo, a cavallo tra il 1664 ed il 1665, d’essere prossimo al capolinea della vita, decide di riconoscere, come erede universale delle proprie sostanze, il nipote Gianmaria, abitante, come detto, nell’Alta Padovana. In pratica, tutti i beni andranno al nipote, a condizione che s’impegni a sostenere economicamente il programma dei religiosi: questa clausola, però, non sarà inserita nel testamento olografo, ma verrà comunicata, anzi caldamente raccomandata a voce all’erede, il quale, alla morte dello zio, si predisporrà ad ottemperare scrupolosamente a tutte le disposizioni del defunto, con evidente giubilo dei frati.
Ma quando la questione sembra aver preso la giusta piega, ecco che l’architetto Matteo Allio, tradendo in parte gli accordi contrattuali, esce con una novità che non manca di recare scompiglio: vorrebbe usare, al posto della pietra d’Istria, il cosiddetto “biancone di Vicenza”, detto anche “marmo biancone Asiago”. Il motivo di tale scelta, oggi, ci sembra abbastanza chiaro: Allio tiene una “bottega” a Vicenza, oltre che a Padova, per cui gli è più comodo ed economico procurarsi questo genere di roccia, al posto del marmo indicato dai frati; inoltre il Grigno non vuole sborsare alcuna somma di denaro per l’acquisto della pietra d’Istria, che costa quasi il doppio del “biancone” vicentino.
I monaci, però, ritengono improponibile la sostituzione del prodotto e puntano con insistenza alla “pietra iftriana ben lauorata”. L’architetto, stizzito, sbatte la porta, minacciando di mandare la trattativa all’aria. Ma gli agostiniani non si lasciano intimorire e, tramite i loro avvocati, fanno inviare una serie di diffide a lui e al signor Grigno, responsabili di non voler rispettare gli accordi. Da questo momento, la storia del portale s’ingarbuglia e procede a suon di fendenti legali o, come si direbbe oggi, “a colpi di carte bollate”.
Il contenzioso si trascinerà per una decina d’anni, durante i quali si sprecheranno le vertenze, le diffide, le ingiunzioni, i controlli, le perizie, le sentenze e i relativi ricorsi. A dire il vero, in quest’arco di tempo non mancheranno gli accomodamenti e le riconciliazioni alla presenza di testimoni, ma poi si riaccenderanno le polemiche, le ripicche e le liti, e inevitabilmente riprenderanno i processi. Quando finalmente sembra risolta la questione del marmo d’Istria, inizia la controversia su come dovrebbero essere i capitelli delle colonne, che i reverendi padri esigono in stile corinzio, mentre i fratelli Allio preferiscono in stile ionico, se non altro perché, nel magazzino della loro bottega, dispongono di un certo numero di capitelli ionici, che potrebbero essere utilizzati all’uopo (particolare forse sottaciuto).
Nel 1667, il podestà, su istanza dei ricorrenti, fa emettere dal Tribunale di Giustizia una sentenza che, oltre a dare ragione ai frati sulla scelta dei capitelli corinzi, ordinerà a Gianmaria Grigno di sborsare a Matteo Allio 125 ducati, allo scopo di far fronte, evidentemente, alla spesa del materiale necessario per avviare i lavori: l’artista, d’altro canto, dovrebbe impegnarsi a completare il portale – rimasto interrotto a causa, appunto, del mancato compenso da parte del committente – in tempi ragionevoli. Ma il Grigno non si fida e fa sapere che sborserà il denaro solo quando avrà visto lo scultore all’opera. Chiede, anzi, al Tribunale che venga effettuato un sopralluogo nel laboratorio di Matteo Allio, per verificare se, effettivamente, i lavori stiano procedendo.
Ecco, allora, che il giudice, nel 1668, nomina tre periti con il compito di eseguire alcuni controlli presso la sede degli Allio. Gli esperti in questione sono Tonio Sforzano (per i frati), il già menzionato Antonio Zanin (per il tribunale) e Giovanni Pizzolato (per lo scultore). Dopo un’accurata ispezione, lo Sforzano prepara un dettagliato resoconto, nel quale riconosce che, presso la bottega di Matteo (il fratello, nel frattempo, è venuto a mancare), si trova svariato materiale lapideo già pronto per la realizzazione del portale. Il verbalizzante annota, tra l’altro, d’aver visto la statua della Modonna con il Bambino e i due angioletti seduti, opera terminata e rifinita, forse, da Tommaso, e un blocco di pietra d’Istria, che servirebbe per le sculture degli arcangeli, nonché una cornice a modiglione e due colonne in marmo lavorato, per la progettazione di una porta ampia ed alta.
Sulla scorta di quanto descritto nel verbale, lo scultore potrebbe ritenersi soddisfatto, ma il suo carattere permaloso non gli permette di indietreggiare, anche perché non è ancora stato pagato dal Grigno che, nel frattempo, lo minaccia di sostituirlo con un altro architetto di Venezia. Perciò, contrariato più che mai, pianta tutti in asso e se ne va a Mantova, dove, tra l’altro, si sospetta abbia lasciato in sospeso altri progetti. Il podestà, allora, nell’autunno 1668, gli fa recapitare una lettera di fuoco, intimandogli l’immediato ritorno: dovrà mettersi all’opera per eseguire i lavori del portale, se non vorrà pagare pesanti penali per l’abbandono del progetto, oltre che provvedere al risarcimento dei danni causati. Questa volta Matteo, messo alle strette, rientra a Padova e, suo malgrado, decide di porre fine alla spinosa trattativa.
Nuova protesta dei frati: il portale non piace

Tuttavia, ai primi di giugno del 1669, gli agostiniani sono nuovamente in fermento: protestano perché il portale, praticamente ultimato e già collocato al proprio posto, non risponde alle loro aspettative e, in particolare, al “decoro” che si conviene al santuario della Beata Vergine di Monteortone, e perciò si appellano al podestà. Ma cosa c’è, ancora, che non va? Dalla lettera, anzi dall’imposizione che il nuovo podestà manda a Gianmaria Grigno, si apprende che questo benedetto portale è “male aggiuftato” e le statue sono “malamente ripofte”, per cui bisogna provvedere al più presto a ripararle e a ricollocarle. Il Grigno, a sua volta, se la prende con lo scultore ed esige che il lavoro sia rifinito a regola d’arte. Ma Matteo, dopo aver replicato d’aver dato il meglio di sé con la realizzazione di un’opera perfetta, lo attacca, rinfacciandogli di non aver ancora ricevuto l’anticipo del compenso pattuito.
Il 9 novembre 1669, si muove il Tribunale di Giustizia, intimando all’architetto- scultore di far perfezionare l’opera rimasta incompiuta. Seguono nuovi sopralluoghi ed ulteriori perizie e, questa volta, Tonio Sforzano scriverà nel verbale che, sì, le colonne sono state poste in stile corinzio, come previsto dalle clausole iniziali del contratto, ma la forma dei capitelli ancora non soddisfa; inoltre, non figurano i due angioletti seduti; quanto agli arcangeli posti ai lati della Madonna, uno manca di mano, braccio, piede e testa, perché i singoli pezzi, essendo stati malamente saldati, sono finiti a terra.
Quisquilie, se si pensa che tutta l’intelaiatura appare troppo incassata all’interno dell’edificio, per cui andrebbe fissata “più fuori dalle muraglie”; che bisognerebbe rendere “più fpiccianti” fuori anche le statue degli arcangeli e rifare gli angioletti. Infine, andrebbero decisamente abbassati gli architravi delle due colonne. Matteo Allio, però, non può contestare e ribattere a questi rilievi, perché, nel frattempo, è passato a miglior vita. A questo punto il Grigno, rassegnato, si rivolge al celebre architetto-scultore Baldassare Longhena (1598-1682), affinché cerchi di riparare le rotture ed eliminare i difetti del tribolato portale, aggiungendovi, possibilmente, qualche spunto originale.
Il tocco sapiente di Baldassare Longhena

Il professionista in questione è tra i più osannati e ricercati nel Veneto. La sua attività si concentra soprattutto a Venezia e nelle sue immediate vicinanze. Famosissimo per aver progettato la basilica di S. Maria della Salute, commissionata dai veneziani come “ex voto”, in seguito alla terribile pestilenza del 1630-’31, possiede un “curriculum” di tutto rispetto, per aver provveduto, tra l’altro, ai rifacimenti di palazzo Malipiero e alle ristrutturazioni di palazzo Giustinian Lolin, nonché per aver lasciato la sua autorevole impronta artistica a Brescia, Chioggia, Loreo, Conegliano e Bassano del Grappa.
Il Grigno è consapevole d’aver trovato un “pezzo da 90”, che sicuramente gli farà fare bella figura, ma non si rende conto che il celebre architetto è come l’Araba Fenice: tutti lo cercano e lo rincorrono invano. E se, per caso, riescono a contattarlo, il professionista è un tipo che dapprima promette, assicura, sottoscrive, ma poi improvvisamente si “volatilizza”: non per malizia, s’intende, o per volersi rendere prezioso, bensì perché è troppo preso dalla realizzazione delle sue opere “in fieri” a Venezia. Perciò, il progetto del portale di Monteortone, ultimo nei suoi pensieri, viene lasciato – come si direbbe oggi – in “stand by”.
Ecco, allora, che gli agostiniani, spazientiti, nel 1672 assumono una grave decisione: si rivolgono nientemeno che al “Gravissimo Tribunale dell’Inquisizione”, affinché i lavori abbiano esito “immediato”. Gli eccellentissimi giudici fanno recapitare un’ingiunzione al mecenate Gianmaria Grigno che, spaventato, si rassegna a sottoscrivere, alla presenza di tre testimoni (il priore fra Lorenzo Fabris e i signori Antonio Zanoni e Carlo Formenti), un documento, con cui s’impegna a far realizzare il portale in conformità al nuovo progetto presentato dal Longhena.
A dire il vero – e per le elementari nozioni d’architettura che abbiamo appreso sui banchi di scuola –, i ritocchi apportati dall’artista ci sembrano limitatamente circoscritti: forse, volendo rispettare il più possibile il progetto originario degli Allio, e non intendendo stravolgere il loro lavoro, il celebre architetto si limitò a togliere o ad aggiungere solo alcuni dettagli, modificando qualche elemento di disturbo ed effettuando dei sapienti ritocchi, specie nella parte superiore e nella mensola centrale del portale.

Enzo Ramazzina