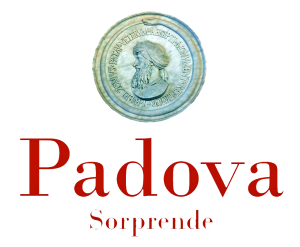Sommario
Abstract
 Amedeo Quondam, già ordinario all’Università La Sapienza di Roma, tra i fondatori dell’Associazione degli Italianisti Italiani di cui divenne Segretario nazionale nel 2002, quindi Presidente nel 2005 e riconfermato nel 2008, è stato uno dei principali critici e storici della letteratura italiana (Roma 1943-2024). Grande estimatore del Petrarca, prima di andarsene aveva dedicato un saggio al grande poeta aretino: “Petrarca, l’italiano dimenticato”, finalista tra l’altro al Premio Viareggio per la saggistica. Per i padovani tuttavia la fortuna della memoria del personaggio non è mai venuta meno nel tempo, soprattutto per il fatto che tra i colli Euganei Petrarca è più vivo che mai, anzi è diventato parte integrante dei Colli Euganei Patrimonio Unesco con il suo Parco Letterario.
Amedeo Quondam, già ordinario all’Università La Sapienza di Roma, tra i fondatori dell’Associazione degli Italianisti Italiani di cui divenne Segretario nazionale nel 2002, quindi Presidente nel 2005 e riconfermato nel 2008, è stato uno dei principali critici e storici della letteratura italiana (Roma 1943-2024). Grande estimatore del Petrarca, prima di andarsene aveva dedicato un saggio al grande poeta aretino: “Petrarca, l’italiano dimenticato”, finalista tra l’altro al Premio Viareggio per la saggistica. Per i padovani tuttavia la fortuna della memoria del personaggio non è mai venuta meno nel tempo, soprattutto per il fatto che tra i colli Euganei Petrarca è più vivo che mai, anzi è diventato parte integrante dei Colli Euganei Patrimonio Unesco con il suo Parco Letterario.
Quondam su Francesco Petrarca
 “Per secoli riconosciuto come padre della tradizione letteraria italiana, memorizzato, imitato, plagiato da schiere di scrittori e poeti [si veda il Bembo!], Francesco Petrarca è stato, nell’Ottocento risorgimentale e romantico, accantonato, quasi rinnegato -scrive Quondam -. Considerato l’emblema di una società aristocratica e clericale, non può non entrare in conflitto con la tensione laica e borghese che anima un popolo in cerca di riscatto dalla dominazione straniera. Lui, simbolo per eccellenza dell’autonomia della poesia e del lavoro intellettuale, non può non scontrarsi con il bisogno di letteratura impegnata, che accende i cuori ai valori politici, etici e civili. Così, nella galleria degli antenati con cui l’Italia fonda la propria identità di nazione, a Petrarca è preferito Dante, poeta filosofo e dell’azione, che ebbe il coraggio di parlare la lingua viva e multiforme del popolo: Dante è il campione della lotta ai tiranni, l’autentico padre degli italiani; Petrarca è il simbolo di una letteratura chiusa in se stessa: è un non italiano, anzi il non italiano per eccellenza”.
“Per secoli riconosciuto come padre della tradizione letteraria italiana, memorizzato, imitato, plagiato da schiere di scrittori e poeti [si veda il Bembo!], Francesco Petrarca è stato, nell’Ottocento risorgimentale e romantico, accantonato, quasi rinnegato -scrive Quondam -. Considerato l’emblema di una società aristocratica e clericale, non può non entrare in conflitto con la tensione laica e borghese che anima un popolo in cerca di riscatto dalla dominazione straniera. Lui, simbolo per eccellenza dell’autonomia della poesia e del lavoro intellettuale, non può non scontrarsi con il bisogno di letteratura impegnata, che accende i cuori ai valori politici, etici e civili. Così, nella galleria degli antenati con cui l’Italia fonda la propria identità di nazione, a Petrarca è preferito Dante, poeta filosofo e dell’azione, che ebbe il coraggio di parlare la lingua viva e multiforme del popolo: Dante è il campione della lotta ai tiranni, l’autentico padre degli italiani; Petrarca è il simbolo di una letteratura chiusa in se stessa: è un non italiano, anzi il non italiano per eccellenza”.
La casa del Petrarca ad Arquà
Quantunque le parole del Quondam possano a certuni apparire discutibili, ecco che cosa scriveva, tra l’altro, il Tommaseo da Sebenico in pieno Ottocento, dopo una visita ad Arquà (e alla villa dell’abate Barbieri a Torreglia): “La casa del Petrarca volge le spalle a tramontana: ha da mezzogiorno un prospetto assai ampio di piano leggiermente ondeggiante, con di fronte un colle non alto, che solo s’innalza, e par che renda l’imagine della Lirica petrarchesca solinga e gentilmente pensosa. Laddove l’epopea dell’Allighieri è catena di montagne, l’una sull’altra sorgenti, con ghiacci e verde, nebbia e sereno, ruscelli e torrenti, fiori e foresta, ardue cime e caverne cupamente echeggianti. Da manca a levante, altre case tolgono la vista de’ colli, che forse un tempo era libera: e certo quelli d’allora erano men poveri e meno eleganti edifizi… Da ponente, a diritta, i poggi sono più presso alla casa, e la rallegrano delle lor forme belle: a ponente è l’orto, che avrà allora avuto certamente un più vago disordine che i giardini moderni, e altre piante che i giuggioli e i fichi d’adesso. A ponente era lo stanzino dello studio, dove il vecchio onorando, inchinando il capo o a preghiera o a meditazione non dissimile dalla preghiera, morì… Accorrevano da molte parti d’Europa e del mondo a vedere la casa di Francesco Petrarca; ed intanto lasciavano che la pioggia e le lucertole entrassero nella sua sepoltura. Ma il conte Carlo Leoni, padovano, assumendo co’ titoli gli obblighi aviti, fece quello che un da Carrara avrebbe fatto potendo, riparò la tomba cadente: né con questo esempio soltanto agl’Italiani raccomandò il proprio nome”.

Casa di Petrarca ad Arquà. Tavola tratta da Reise nach Venedig, 1824. Da BEIC, biblioteca digitale
Francesco dall’Ongaro
 Si finisce citando un sonetto del poeta patriota risorgimentale mazziniano, Francesco Dall’Ongaro, trevigiano, esule in Belgio dove illustrava soprattutto “La Divina Commedia”. Titolo: “La Tomba di Arquà”: “Qui chiuse gli onorati anni Petrarca,/ Qui fra l’ombre beate, e l’aque, e i fiori/ Riposò la soave anima scarca/ Dal pondo delle cure e degli onori.//E mentre lo molcea fin presso all’arca/ La rimembranza de’ suoi lunghi amori,/ Nutria la mente intemerata e parca/ D’opre, d’affetti e di pensier migliori.//Felice, onesto, sapiente e pio/ Trattò co’ regi, e non spregiò l’umìle,/ Servì l’altare, amò la patria e Dio.// O amici, in questa dura età servile,/ Ch’ogni antica virtù pose in oblio,/ E’ gloria amarlo e non tenerlo a vile”.
Si finisce citando un sonetto del poeta patriota risorgimentale mazziniano, Francesco Dall’Ongaro, trevigiano, esule in Belgio dove illustrava soprattutto “La Divina Commedia”. Titolo: “La Tomba di Arquà”: “Qui chiuse gli onorati anni Petrarca,/ Qui fra l’ombre beate, e l’aque, e i fiori/ Riposò la soave anima scarca/ Dal pondo delle cure e degli onori.//E mentre lo molcea fin presso all’arca/ La rimembranza de’ suoi lunghi amori,/ Nutria la mente intemerata e parca/ D’opre, d’affetti e di pensier migliori.//Felice, onesto, sapiente e pio/ Trattò co’ regi, e non spregiò l’umìle,/ Servì l’altare, amò la patria e Dio.// O amici, in questa dura età servile,/ Ch’ogni antica virtù pose in oblio,/ E’ gloria amarlo e non tenerlo a vile”.
Gianluigi Peretti
Fonti: rivista “Veneto&Veneti”, anno I, n. 2, 2008 – “I colli Euganei”, riedizione anastatica Atesa Editrice, autori vari, 1978